ISTAT (Istituto nazionale di statistica)
Nota 06/06/2024
La corruzione in italia| Anno 2022-2023.
Emanata dall'Istituto nazionale di statistica.
Epigrafe
Premessa
Un milione e 200mila famiglie coinvolte
Corruzione in diminuzione negli ultimi tre anni
Richieste in più ambiti per il 15% delle famiglie
Richiesta diretta dell'interessato a circa 94mila famiglie
L'8,3% dei cittadini conoscono persone coinvolte in richieste di denaro o favori
Il voto di scambio, una pratica ancora diffusa ma in diminuzione
Tra imprenditori e lavoratori autonomi cresce la percezione di richieste illecite
Corruzione più accettata se serve a trovare lavoro a un figlio
Combattere la corruzione denunciando, favorevole oltre il 90% dei cittadini
Nota metodologica
Nota 6 giugno 2024 (1)
La corruzione in italia| Anno 2022-2023.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di statistica.
In calo le richieste alle famiglie di denaro o altro in cambio di agevolazioni, beni o servizi
Nell'ultima indagine (2022-2023) si riscontra una diminuzione dal 2,7% al 1,3% delle richieste ricevute dalle famiglie nel triennio precedente l'intervista rispetto all'edizione del 2015-2016; i cali più consistenti riguardano i settori lavoro, uffici pubblici, sanità e giustizia.
Nel corso della loro vita si stima che il 5,4% delle famiglie abbia ricevuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di agevolazioni, beni o servizi; le richieste più frequenti al Centro (6,8%), meno nelle Isole (3,6%).
Diminuisce anche la quota di chi conosce persone che hanno avuto esperienze di corruzione: dal 13,1% (2015-2016) all'8,3% (2022-2023).
Le domande utili a studiare il fenomeno della corruzione sono state introdotte per la prima volta nell'Indagine sulla sicurezza dei cittadini nel 2015-16, approfondimento ripetuto nell'edizione dell'Indagine 2022-23. L'obiettivo è stimare il numero di famiglie coinvolte in dinamiche corruttive: alle persone tra i 18 e gli 80 anni di età viene chiesto, infatti, se a loro stessi o ad un familiare convivente sia stato suggerito o richiesto di pagare, fare regali o favori in cambio di facilitazioni per avere un servizio o un'agevolazione. L'attenzione è rivolta alle esperienze dirette e si approfondisce con domande dedicate se vi siano stati scambi, di quali entità, con quali modalità e quali esiti, oltre all'eventuale denuncia dell'episodio. È rilevata anche la conoscenza indiretta di casi di corruzione: viene chiesto al rispondente se fatti simili siano accaduti nel proprio ambiente ad amici, colleghi e familiari.
Tutte queste situazioni sono esplorate in otto settori chiave: sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici pubblici, giustizia, forze dell'ordine, public utilities, tenendo conto dell'effettivo contatto dei rispondenti con i servizi e/o le figure rilevanti per ciascun settore specifico.
Alcune domande, invece, vengono dedicate al fenomeno del voto di scambio per le elezioni amministrative, politiche ed europee. Viene inoltre rilevata la percezione della diffusione della corruzione nell'ambiente delle imprese e della libera professione e, per la prima volta, sono state raccolte alcune informazioni sull'accettabilità della corruzione da parte dei cittadini.
Trattandosi in alcuni casi di dati numericamente esigui, si è scelto di riportare nel report solo i dati statisticamente significativi, in base all'errore campionario [1].
[1] Per la valutazione dell'errore si rimanda alla nota metodologica. Nel caso comunque vengano presentate stime con errori superiori al 35%, questa informazione è riportata nelle figure.
Un milione e 200mila famiglie coinvolte
Si stima che sia il 5,4% [2] la quota di famiglie in cui almeno un componente abbia ricevuto nel corso della vita richieste di denaro, favori, regali o altro per ottenere agevolazioni o servizi; la quota è dell'1,3% se si considerano gli ultimi tre anni precedenti l'intervista come arco di tempo in cui è avvenuta la richiesta e lo 0,5% se si prendono a riferimento gli ultimi 12 mesi.
Pressoché tutte le famiglie hanno avuto necessità di ricorrere ad alcuni uffici per soddisfare uno specifico bisogno: è questo il caso del settore dell'istruzione (promozioni scolastiche, esami di maturità o universitari, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione), dell'ambito sanitario (visite mediche, accertamenti diagnostici, ricoveri o interventi chirurgici), delle public utilities (allacci, volture o riparazioni per l'energia elettrica, il gas, l'acqua o la rete telefonica), dei vari uffici pubblici (uffici del comune, della regione, vigili del fuoco, ASL, agenzia delle entrate, motorizzazione, ecc.) o anche per la ricerca del lavoro, promozioni o trasferimenti in ambito lavorativo.
Più raramente ci si rivolge alle forze dell'ordine (20% delle famiglie), si è parte in causa in un processo civile, in un processo penale o in una causa di tipo amministrativo (16,5%) o si richiedono servizi assistenziali, come sussidi economici, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento o altri benefici assistenziali (10,5%).
Famiglie che si sono rivolte ad uffici e che hanno ricevuto richieste di denaro, regali o altro nel corso della vita e negli ultimi 3 anni per settore.
Anno 2022-23, valori in migliaia e per 100 famiglie che si sono rivolte ad un ufficio/hanno avuto bisogno di un servizio
Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza dei cittadini
(*) dato con errore campionario superiore al 35%.
[2] Il dato è calcolato sulle famiglie che hanno esperito almeno un episodio di corruzione negli otto settori considerati nel corso della vita e sugli imprenditori o liberi professionisti cui è capitato di pagare per ottenere agevolazioni sul lavoro.
Corruzione in diminuzione negli ultimi tre anni
Tra le famiglie che si sono rivolte alla sanità nel corso della loro vita (21milioni 950mila), l'1,3% (circa 295mila) ha avuto richieste di denaro, regali o altro per ottenere o velocizzare il servizio o per ricevere assistenza. In ambito lavorativo ciò è capitato allo 0,8% delle famiglie (circa 179mila); per essere agevolati nel settore dell'istruzione allo 0,7% delle famiglie (circa 164mila), mentre una percentuale più bassa riguarda l'ambito delle public utilities: è pari allo 0,4% (circa 87mila) la quota di famiglie che al momento della domanda di allacci, volture o riparazioni per l'energia elettrica, il gas, l'acqua o il telefono ha avuto richieste di pagamenti in qualsiasi forma per ottenere o velocizzare i servizi. Invece il 2% (circa 427mila famiglie) ha avuto richieste di denaro o regali rivolgendosi ad uffici pubblici.
Nel settore della giustizia il 4,8% delle famiglie (circa 175mila su 3milioni 643mila) ha avuto una richiesta di denaro, regali o favori da parte di un giudice, un pubblico ministero, un cancelliere, un avvocato, un testimone o altri. In particolare, il 2,9% ha avuto simili richieste in occasioni di cause di tipo amministrativo e l'1,8% per cause civili.
Per i benefici assistenziali, in caso di domanda di contributi, sussidi, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità, la richiesta di denaro, favori o regali ha coinvolto il 2,7% delle famiglie (62mila su circa 2 milioni 335mila). Mentre è lo 0,4% delle famiglie che, rivolgendosi alle forze dell'ordine nel corso della vita, ha avuto richieste più o meno esplicite di denaro, regali o altro per avere facilitazioni, ottenere ciò di cui avevano bisogno o per avere un occhio di riguardo (circa 16mila su 4 milioni 426mila).
La graduatoria dei settori per i quali le famiglie hanno dichiarato richieste "improprie" nel corso della vita si modifica nei tre anni precedenti l'Indagine solo per il settore dell'assistenza che si colloca al primo posto (1,4%).
Il confronto tra il dato dei tre anni precedenti l'intervista, anni 2020-2023 (considerando che la rilevazione è stata effettuata tra il 2022 e il 2023) con gli anni 2013-2016, relativi all'indagine precedente (rilevazione effettuata tra il 2015 e il 2016) evidenzia una diminuzione netta del fenomeno: si va dal 2,7% delle famiglie che hanno subito almeno una richiesta di denaro, regali o altro, all'1,3% per gli ultimi tre anni. Il dato è sicuramente condizionato dalla pandemia da Covid-19 che tra il 2020 e il 2021 può avere alterato anche il ricorso stesso ad alcuni servizi.
L'unico settore in cui la corruzione non appare in calo è quello assistenziale, rimasto stabile al valore di 1,4% (circa 33mila famiglie). Al contrario, la diminuzione, statisticamente significativa, è più ampia in ambito lavorativo e per le richieste negli uffici pubblici. Si sono dimezzate le richieste in ambito sanitario e sono un quarto di meno nel settore giustizia.
La maggior parte delle famiglie che ha ricevuto richieste di denaro o altro per ottenere facilitazioni, ha ricevuto una sola richiesta nel corso della vita (circa il 59%, 709mila), il 20,3% due e l'8,6% tre o più, mentre il 12% ha preferito non rispondere o ha dichiarato di non ricordare. Nel settore dell'istruzione, lavoro, uffici pubblici e public utilities è maggiore la frequenza di subire più volte le richieste di denaro o altro.
Figura 1. Famiglie che hanno ricevuto, nel corso della vita, richieste di denaro, regali o altro per ottenere agevolazioni o servizi, per numero di episodi di corruzione e settore.
Anno 2022-23 per 100 famiglie che hanno avuto richieste (totale famiglie = 1 milione200mila)
Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza dei cittadini
Richieste in più ambiti per il 15% delle famiglie
Sebbene le esperienze di corruzione non siano particolarmente diffuse, nel momento in cui si è vittime non solo si ha una probabilità maggiore di subire episodi multipli nell'ambito dello stesso settore (la cosiddetta multi-vittimizzazione), ma ciò può accadere anche nell'ambito di diversi settori. Questo fenomeno, che si definisce pluri-vittimizzazione, colpisce circa il 15% delle famiglie (183.332) che hanno esperito episodi corruttivi: al 13,0% delle famiglie è capitato in due settori, allo 1,8% in tre settori e allo 0,4% in quattro o più. Questa realtà è più diffusa al Sud e nelle Isole, circa il 20% per entrambe le ripartizioni.
Le richieste di denaro o altro in cambio di favori ricevute nel corso della vita, sono state maggiormente segnalate dalle famiglie residenti al Centro (6,8%) e meno nelle Isole (3,6%). Ma, a seconda dei settori considerati, varia la propensione a subirla: per il settore giustizia ad esempio risalta il Sud (6,7%).
A livello regionale emerge il Lazio (10,4%), segue la Basilicata (7,1%); sono di poco sopra la media la Campania (6,6%) e l'Emilia Romagna (6,7%).
Un'altra dimensione da tenere presente è legata alle caratteristiche del comune di residenza. Le famiglie che vivono nei centri delle aree metropolitane hanno subito maggiori richieste di denaro o altro in cambio di favori, beni o servizi (8,3%), seguite da chi vive nelle periferie delle aree metropolitane (7,2%); percentuali minori riguardano le famiglie che abitano nei piccoli comuni e nei centri con più di 50mila abitanti.
Se si considera il livello di istruzione come una buona proxy dello status socio-economico, il 6,5% delle famiglie che, nel corso della vita, ha ricevuto almeno una richiesta di denaro, favori o regali ha almeno un componente con titolo di studio elevato, contro il 4,8% delle famiglie senza componenti con titolo di studio elevato, con l'eccezione per il settore dell'assistenza, con cui entrano in contatto famiglie meno abbienti. Il dato ha una tendenza analoga se si considera la posizione nella professione: sono il 6,9% le famiglie che hanno almeno un componente con condizione professionale elevata (dirigenti, quadri, imprenditori e liberi professionisti) e che hanno ricevuto proposte di dare denaro, regali o altro, contro il 5,1% delle altre professioni.
Unico settore in controtendenza è quello afferente alla giustizia, dove la situazione si inverte: hanno ricevuto più richieste le famiglie con posizioni professionali meno elevate (5,2%) rispetto a quelle a quelle con imprenditori, liberi professionisti, dirigenti e quadri.
Figura 2. Famiglie in cui almeno un componente ha ricevuto, nel corso della vita e negli ultimi tre anni, richieste di denaro, regali o altro per ottenere agevolazioni o servizi, per ripartizione.
Anno 2022-23, per 100 famiglie della stessa zona (totale famiglie = 22milioni 143mila)
Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza dei cittadini
Richiesta diretta dell'interessato a circa 94mila famiglie
Alle famiglie che hanno subito episodi di corruzione nei tre anni precedenti l'intervista (circa 297mila) sono state poste domande di approfondimento sulla dinamica dell'ultimo evento, vissuto in prima persona dall'intervistato o da altri componenti della famiglia.
Nella maggior parte dei casi di corruzione c'è stata una richiesta esplicita da parte del diretto interessato (la stima è pari al 31,5%, circa 94mila famiglie) o questi lo ha fatto capire (33,0%); segue la richiesta da parte di un intermediario (22,6%). In altri casi le famiglie riportano che non vi è stata una vera e propria richiesta dal momento che "si sa che funziona così" (8,1%), mentre in un residuale 2,1% è il cittadino ad avere offerto di propria iniziativa denaro o regali. Tuttavia, a questa domanda il 4,4% degli intervistati si è rifiutato di rispondere e il 4,3% ha detto di non ricordare o di non sapere come si fosse svolto il fatto. La richiesta da parte di intermediari è più frequente in sanità (29,6%), mentre nel settore degli uffici pubblici si è esposto il diretto interessato che lo ha fatto capire (41,3%).
Il denaro è il tipo di richiesta più frequente alle famiglie (66,4%), segue lo scambio di un favore (9,4%) e un regalo nell'8,9% dei casi (al Sud 15,2%). Residuali un trattamento privilegiato (1,8%) e una prestazione sessuale (1,6%). Al 4,8% delle famiglie, infine, sono stati chiesti altri beni.
Alcune domande sulla dinamica corruttiva, accaduta nei tre anni, sono state poste solo agli intervistati che hanno riportato i casi di corruzione vissuti da loro in prima persona (221mila). Si tratta ad esempio dei quesiti inerenti il pagamento richiesto, il suo ammontare, l'utilità dello scambio corruttivo, un nuovo eventuale pagamento in cambio di servizi e le motivazioni della non denuncia.
Il 37,1% delle famiglie ha risposto alla richiesta con denaro o regali (oltre la metà dei casi al di sotto dei 500 euro). In ambito sanitario, la quota di chi acconsente alla richiesta sale al 46%.
Ma, tra le famiglie che hanno corrisposto alla richiesta (circa 82mila) quanto è stata utile la "transazione" per ottenere il servizio? A questa domanda le famiglie hanno risposto affermativamente nel 77,4% dei casi (circa 63.500). Circa tre quarti delle persone che dichiarano l'utilità di avere pagato o fatto regali in cambio di beni o servizi o agevolazioni hanno dichiarato che lo rifarebbero.
Denunciare la corruzione è un fenomeno raro, lo ha fatto, nel corso degli ultimi tre anni, il 2% delle famiglie cui è stato chiesto denaro, regali o altro ed è elevata la quota di chi non risponde o non sa se sia stato denunciato l'episodio (10%). I motivi della non denuncia sono stati chiesti solo ai rispondenti che hanno riportato in prima persona l'evento subito e che non hanno denunciato (circa 216mila).
Prevale la consuetudine della pratica per raggiungere i propri obiettivi (29,3%) e l'utilità del vantaggio avuto a seguito della transazione corruttiva (19,4%), motivi questi due riportati soprattutto da chi ha esperito la corruzione in ambito sanitario. A seguire il 17,7% ritiene inutile denunciare, il 13,7% ha risolto in altro modo e ha preferito lasciar perdere, altri invece asseriscono che non essendo una richiesta esplicita e in assenza di prove le forze dell'ordine non potevano fare nulla (9,3%) e un 3,7% ha asserito di non sapere a chi avrebbe potuto denunciare.
Figura 3. Famiglie che hanno avuto richieste di denaro, regali, o altro per ottenere agevolazioni o servizi negli ultimi tre anni, per modalità della richiesta.
Anno 2022-2023, per 100 famiglie cui è accaduto (totale famiglie = 297mila)
Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza dei cittadini
L'8,3% dei cittadini conoscono persone coinvolte in richieste di denaro o favori
È pari all'8,3% (3milioni 643mila su circa 44milioni di persone di 18-80 anni) la percentuale di persone che conoscono qualcuno - parenti, amici, colleghi o vicini - a cui è stato richiesto denaro, favori o regali per ottenere agevolazioni nei diversi ambiti qui considerati, dato anche questo in diminuzione (-36,6%) rispetto all'Indagine precedente (2015-2016), quando si attestava al 13,1%. La situazione varia a seconda del settore coinvolto: dal 4,6% per il settore del lavoro al valore minimo per le forze dell'ordine e le public utilities (rispettivamente 1,0%). Tra le due indagini sono statisticamente significative le diminuzioni soprattutto per il settore sanità (-64,4%), assistenza (-52,2%), lavoro (-35,2%) e public utilities.
Sono gli abitanti dei comuni tra 10mila e 50mila abitanti (11,3%) e i cittadini del Sud (12,1%) che in misura maggiore segnalano di conoscere persone a cui sono state fatte richieste di denaro o altro in cambio di favori, un dato comunque in diminuzione quest'ultimo rispetto al 19,7% del 2015-2016.
La variabilità tra le regioni è elevata, con picchi in Campania (13,6%), Puglia (13,0%), Piemonte (12,5%) e Sardegna (12,4%) e valori sotto la media per il Friuli Venezia Giulia (3,1%) e le Provincie Autonome di Trento (3,7%) e Bolzano/Bozen (0,2%).
La conoscenza di persone a cui è capitato di ricevere richieste di denaro o altro per ottenere agevolazioni o servizi è associata alla propria esperienza diretta: i cittadini che hanno vissuto in prima persona le richieste di "corruzione" conoscono altri a cui è accaduto nel 37,5% dei casi, mentre nel caso in cui non si sia stati coinvolti direttamente la conoscenza di altre persone a cui è accaduto si riduce al 6,8%.
Figura 4. Persone che conoscono qualcuno (amici, parenti, colleghi) a cui è stato richiesto denaro, favori, regali per ottenere agevolazioni o servizi, per principali settori.
Anni 2015-2016 e 2022-2023, per 100 persone di 18-80 anni (totale persone 2022-2023 = 43millioni 968mila)
Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza dei cittadini
Il voto di scambio, una pratica ancora diffusa ma in diminuzione
Nel nostro Codice penale il voto di scambio è classificato fra i reati contro l'ordine pubblico con la denominazione di "scambio elettorale politico-mafioso" (art. 416ter del Codice Penale). Pur con una diversa classificazione giuridica rispetto alla corruzione - che è un reato contro la P.A. - il voto di scambio ne condivide, per alcuni aspetti, la fenomenologia. In questo caso il pactum sceleris avviene fra un elettore e un politico, o un suo intermediario, che trasformano in oggetto di scambio quel voto che secondo la nostra Costituzione (art. 48) dovrebbe essere "eguale, libero e segreto".
Si stima che ad oltre 1milione 166mila cittadini (il 2,7% della popolazione fra i 18 e gli 80 anni) siano stati offerti denaro, favori o regali per avere il loro voto alle elezioni amministrative, politiche o europee; tale quota di cittadini era pari al 3,7% nel 2015-2016. Il voto di scambio è più frequente in caso di elezioni amministrative (1,9% dei cittadini nel 2022-2023) e meno per le elezioni politiche ed europee (0,9%). I picchi più alti sono al Sud (4,2%) e nel Centro (3,6%), sebbene sia proprio il Sud a segnalare una forte diminuzione (da 6,7% a 4,2%).
In cambio del voto sono stati offerti o promessi soprattutto favori o trattamenti privilegiati (29,3%), beni di valore minore, come pranzi, cene o buoni alimentari o di benzina (20%), nomine o posti di lavoro (19,6%), denaro (11,5%) e regali (9,8%).
La richiesta del voto in cambio di agevolazioni o altro, è più frequente tra chi ha avuto anche richieste di "corruzione": la percentuale raggiunge il 17,4% rispetto al valore medio del 2,7%.
L'indagine rileva anche l'esperienza indiretta del voto di scambio. Il 3,8% degli italiani tra i 18 e gli 80 anni di età dichiara di conoscere personalmente qualcuno - parenti, amici, colleghi, vicini - a cui è stato offerto qualcosa in cambio del voto in qualche tornata elettorale. Un dato questo che si è più che dimezzato (-54,2%) rispetto alla rilevazione precedente. Anche in questo caso il primato spetta a Sud (7%) e Isole (4,9%), entrambe le ripartizioni con una diminuzione rispettivamente di circa 9 e 10 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente.
Figura 5. Persone cui è stato chiesto il voto alle elezioni amministrative, politiche o europee in cambio di favori, denaro o regali per ripartizione geografica e tipo di comune.
Anni 2015-2016 e 2022-2023, per 100 persone di 18-80 anni (totale persone 2022-2023 = 43millioni968mila)
Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza dei cittadini
Tra imprenditori e lavoratori autonomi cresce la percezione di richieste illecite
Secondo il 38,5% degli imprenditori, liberi professionisti e lavoratori in proprio (circa 2milioni e 900mila nel 2022-2023) capita di essere obbligati (sempre o spesso) a pagare per ottenere licenze e concessioni o contratti con la P.A., permessi per l'import e l'export, oppure per agevolare pratiche fiscali o velocizzare procedure giudiziarie. La percezione della diffusione della corruzione risulta, dunque, in crescita rispetto a quella, già rilevante, stimata nell'Indagine precedente (32,4%).
Gli imprenditori e i lavoratori autonomi intervistati che presentano una maggiore percezione della diffusione della corruzione sono quelli che lavorano nell'ambito dell'industria e delle attività manifatturiere, il 71,5% dei quali (circa 986mila) ritiene che si sia obbligati a pagare sempre o spesso per almeno uno dei servizi o facilitazioni citati. Seguono coloro che svolgono le proprie attività nei settori delle costruzioni (circa 516mila) e dell'agricoltura, caccia e pesca (circa 361mila). È, invece, il settore delle intermediazioni monetarie e finanziarie quello in cui meno intervistati dichiarano che si è costretti a pagare sempre o spesso per i servizi o i favori citati (circa 29mila).
Secondo i lavoratori autonomi risulta di particolare rilevanza la percezione relativa all'ambito dei contratti con la PA, per i quali per oltre un rispondente su quattro (il 25,2%, circa 1milione e 897mila) dichiara che in genere si è obbligati a pagare sempre o spesso. Riguardo l'agevolazione di pratiche fiscali e l'ottenimento di licenze o concessioni, ci si attesta rispettivamente al 16,2% e al 15,4%. La corruzione percepita come meno diffusa è quella attinente le procedure giudiziarie e i permessi per l'import e l'export.
Figura 6. Opinione di imprenditori, liberi professionisti e lavoratori in proprio sulla diffusione della corruzione nel loro settore di attività per tipo di servizio o facilitazione richiesta.
Anno 2022-2023, per 100 imprenditori, liberi professionisti o lavoratori in proprio che non hanno ricevuto richieste dirette (totale persone= 7milioni525mila)
Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza dei cittadini
Corruzione più accettata se serve a trovare lavoro a un figlio
Nel 2022-2023 sono stati introdotti dei quesiti volti a rilevare la tolleranza verso il fenomeno della corruzione, rivolto ai rispondenti che non hanno ricevuto alcuna richiesta di denaro, regali o altre utilità per ottenere agevolazioni o servizi.
Alle persone non esposte direttamente a episodi corruttivi è stato chiesto se ritenessero accettabili (o almeno in alcune circostanze) comportamenti legati a dinamiche simili o assimilabili a quelle corruttive. In particolare è ritenuto accettabile che un genitore offra o accetti di pagare per trovare lavoro a un figlio da circa 8milioni e 695mila cittadini (il 20,1% dei cittadini di 18-80 anni; per il 7,4% è sempre accettabile, per il 12,7% solo in alcune circostanze), mentre farsi raccomandare da familiari o amici per essere assunto è ritenuto accettabile per il 15,9%. Solo il 4,5% (1milione 947mila) dei cittadini ritiene, invece, accettabile ottenere regali, favori o denaro in cambio del proprio voto alle elezioni.
La vicinanza a fenomeni di scambio illegale favorisce l'accettazione di comportamenti illeciti. La quota di persone che esprimono tolleranza è più alta tra coloro che hanno dichiarato di conoscere qualcuno a cui è stato richiesto di fornire denaro o altro in cambio di beni o servizi. Questa maggiore indulgenza riguarda particolarmente i comportamenti collegati all'ottenimento di un impiego per sé (il 24,2% lo ritiene accettabile, almeno in alcune circostanze) o per un proprio figlio (28,7%).
La tolleranza viene espressa, invece, in quota minore tra gli imprenditori e i lavoratori autonomi che personalmente non hanno ricevuto alcuna richiesta, in particolare la raccomandazione da parte di familiari o amici per essere assunto è ritenuta accettabile solo dall'11,8%; che un genitore offra denaro per trovare lavoro a un figlio dal 17,3%; cercare di ottenere benefici assistenziali cui non si avrebbe diritto dal 4,3%; offrire denaro a figure professionali dal 3,7% e ottenere regali, favori o denaro in cambio del proprio voto dal 3,3%.
La tolleranza espressa varia in qualche misura a seconda del contesto, e risulta più frequente per chi vive in comuni centro di aree metropolitane (offrire denaro è accettabile per il 12% dei cittadini, farsi raccomandare per il 21,4%, ottenere benefici assistenziali senza diritto per l'11%, pagare per trovare lavoro a un figlio per il 24,1% e ottenere qualcosa in cambio del proprio voto per il 9,5%). Nelle regioni del Centro, che sono anche quelle che soffrono la maggiore prevalenza del fenomeno, si evidenzia una tolleranza superiore rispetto all'offrire denaro (11,1%), ottenere benefici assistenziali senza diritto (10,7%) e ottenere qualcosa in cambio del proprio voto (9,3%), mentre riguardo il farsi raccomandare, oltre che al Centro (17,6%), la tolleranza risulta più diffusa al Nord-ovest (17,6%), e riguardo il pagare per trovare lavoro a un figlio al Sud (23,4%).
Figura 7. Persone che ritengono accettabile, o accettabile almeno in alcune circostanze, comportamenti legati a dinamiche corruttive.
Anno 2022-2023, per 100 persone di 18-80 anni che non hanno ricevuto richieste dirette (totale = 43milioni338mila)
Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza dei cittadini
Combattere la corruzione denunciando, favorevole oltre il 90% dei cittadini
Oltre il 90% dei cittadini si dichiara molto o abbastanza d'accordo con le affermazioni "tutti dovremmo combattere la corruzione denunciando i casi di cui si viene a conoscenza" (90,7%, 39milioni e 300mila) e "la corruzione è un danno per la società" (92,4%, circa 40 milioni). L'accordo tuttavia risulta meno diffuso tra le persone meno istruite e tra quelle che risiedono al Sud (rispettivamente 85,8% e 86,8%) e nelle Isole (rispettivamente 87,6% e 91,0%).
Concordano con l'affermazione che la corruzione fa aumentare i costi che i cittadini devono pagare per i servizi (77,1%) soprattutto i cittadini del Nord-ovest (83,0%), meno quelli del Nord-est (71,1%). Sono d'accordo più i laureati (87,0%) e coloro che hanno dichiarato di conoscere persone cui sono state fatte richieste per ottenere beni o servizi (84,2%), meno concordi imprenditori e lavoratori autonomi (70,5%).
Le persone che si dicono molto o abbastanza d'accordo con l'affermazione "Denunciare fatti di corruzione è pericoloso" sono il 63,4%; sia tra le persone che conoscono qualcuno cui sono state fatte richieste sia tra gli imprenditori e i liberi professionisti questa percentuale è sensibilmente maggiore, rispettivamente il 74,5% e il 75,7%. Al Centro la quota è più elevata (68,5%) e al Sud più contenuta (59,6%). I picchi si hanno per la Provincia di Bolzano/Bozen, Umbria, Marche, Toscana, Sardegna, Puglia e Friuli Venezia Giulia, con valori tra il 70 e l'80%.
Meno diffuso è invece l'accordo rispetto all'affermazione per cui "la corruzione riguarda solo le grandi imprese e i politici" (31,8% molto o abbastanza d'accordo), percentuale che supera il 35% per il Nord-ovest e il Centro, diminuisce al 25% circa per il Nord-est e tra gli under 34enni (29,2%). Anche l'"inevitabilità" della corruzione è un'opinione meno diffusa: il 29,4% dei cittadini ritiene che la corruzione sia naturale e inevitabile, sebbene questa percentuale raggiunga il 38,6% al Centro e soprattutto sia più elevata (51,3%) tra quelli che conoscono personalmente chi ha vissuto episodi di corruzione.
L'accordo circa l'affermazione "denunciare i fatti di corruzione è inutile" è ancora minore (23,1% dei cittadini), con quote maggiori per chi ha un titolo di studio medio basso (26,1% tra chi ha la licenza media e 28,2% licenza elementare o nessun titolo di studio). Anche in questo caso esistono differenze territoriali: risulta più elevata nel Sud (29,5%) e nel Centro (26,7%).
Ma qual è l'opinione su chi denuncia episodi di corruzione? Le opinioni sono decisamente positive per il 95,7% dei cittadini, solo il 3,1% ha indicato definizioni connotate negativamente, con quote maggiori al Sud (5%) e al Centro (4,1%). Il 56,5% definirebbe chi denuncia episodi di corruzione una persona onesta, il 22,3% una persona coraggiosa, il 10,3% una persona responsabile e una persona integra il 6,6%. L'onestà è dunque la prima caratteristica indicata, ma il coraggio assume una rilevanza particolare in alcuni sottogruppi: tra gli imprenditori e i liberi professionisti la definizione di persona coraggiosa è scelta dal 32,9%, mentre tra chi conosce persone che hanno ricevuto richieste di corruzione è scelta dal 29,3%.
Le opinioni negative sono residuali: chi denuncia episodi di corruzione viene definito una "persona intransigente" dall'1,3%, una spia (0,6%), una persona vendicativa (0,5%), una persona stupida ed ingenua (0,5%), un traditore (0,2%).
Figura 8. Persone molto o abbastanza d'accordo con alcune affermazioni inerenti il tema della corruzione, per ripartizione geografica.
Anno 2022-2023, per 100 persone di 18-80 anni che non hanno ricevuto richieste dirette (totale = 43milioni 338mila)
Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza dei cittadini
Nota metodologica
Il modulo sulla corruzione e gli obiettivi conoscitivi
L'Istat ha deciso di rilevare le esperienze dei cittadini rispetto alla corruzione già dal 2011, quando la prima Commissione scientifica Istat - CNEL sul Benessere Equo e Sostenibile (BES) manifestò l'esigenza di avere indicatori adeguati nel dominio "sicurezza" per poter rappresentare il fenomeno e il loro impatto sui cittadini. In assenza di dati che potessero rilevare anche il sommerso e non solo l'aspetto giuridico del fenomeno, rilevabile grazie ai dati giudiziari, in quell'occasione fu scelto di progettare un modulo sperimentale che è stato poi inserito nella indagine di vittimizzazione sulla Sicurezza dei cittadini. L'obiettivo era quello di avere dati di misurazione oggettiva della prevalenza e della incidenza del fenomeno e non indicatori di percezione.
A tal fine è stato progettato nel 2014 e 2015 un modulo che aveva come principale scopo la conoscenza della parte sommersa del fenomeno, i settori più coinvolti nella dinamica corruttiva, l'humus in cui la corruzione cresce e di cui si alimenta.
Il focus principale è la corruzione minore, chiamata petty corruption, che si esplicita nella interazione tra i cittadini e i pubblici ufficiali. Tuttavia, dopo la fase di progettazione, si è scelto di non focalizzarsi esclusivamente sul settore pubblico, ma di allargare l'indagine anche al settore privato, in linea con la Legge in materia di corruzione del 2012 che ha introdotto la corruzione nello scambio tra privati.
La fase della progettazione è consistita nella revisione della letteratura nazionale ed internazionale, nella conduzione di focus group con esperti del settore e interviste a testimoni privilegiati.
Come esperti sono stati presi in considerazione giudici, giornalisti, accademici, politici, rappresentanti di associazione di categoria, esponenti di associazioni e dell'ANAC. A livello internazionale sono stati punti di riferimento UNODC e la World Bank.
Nel 2018 le Nazioni Unite hanno prodotto un manuale volto a supportare i Paesi nella misurazione della corruzione attraverso le indagini (Manual On Corruption Surveys. Methodological guidelines on the measurement of bribery and other forms of corruption through sample surveys (https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf), finalizzato alla misurazione del goal 16, target 5: "Ridurre sostanzialmente la corruzione e le tangenti in tutte le loro forme" e in particolare dell'indicatore 16.5.1: Percentuale di persone che hanno avuto almeno un contatto con un funzionario pubblico e che hanno pagato una tangente a un funzionario pubblico, o a cui è stata chiesta una tangente da quel funzionario pubblico, nei 12 mesi precedenti.
Ma il lavoro sulla misurazione non si è fermato alla stima dei goal, bensì ha preso in considerazione molti altri indicatori necessari a rappresentare un fenomeno complesso come è la corruzione. Si tratta di un sistema complesso di statistiche, composto da circa 150 indicatori, sulla misurazione diretta e indiretta dell'esperienza di corruzione vissuta da famiglie e imprese, sulla percezione della corruzione, sugli indicatori di rischio e sulla risposta dello Stato; indicatori che riguardano le diverse forme della corruzione, così come riportate dalla Convenzione internazionale per la lotta alla corruzione - United Nations Convention against Corruption (https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/corruption/UNODC_Statistical_Framework_to_measure_corruption.pdf).
La scelta finale è stata la costruzione di un modulo da inserire nell'Indagine sulla Sicurezza dei cittadini. Temi prevalenti sono la rilevazione dell'esperienza diretta della corruzione in otto settori: l'ambito sanitario e delle cure, quello dell'assistenza, dell'istruzione (a scuola o all'università), del lavoro (per avere un posto di lavoro o per ottenere benefici come trasferimenti, promozioni, aumenti o altro), quello legato all'accesso e all'utilizzo di uffici pubblici, quello della giustizia, del rapporto con le forze dell'ordine e le forze armate e dell'accesso ai servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, luce, acqua, telefonia).
Per ognuno di questi settori, nel caso si siano verificati uno o più episodi di corruzione negli ultimi tre anni, si rileva la dinamica della corruzione, se ad esempio vi è stata una interazione diretta tra le parti coinvolte o la presenza di intermediari, il tipo di scambio e la sua entità, nonché l'utilità dello scambio e il comportamento di denuncia alle autorità competenti.
Inoltre, è emersa anche l'importanza di rilevare la corruzione conosciuta indirettamente, cioè se si è conoscenza che altri nel proprio entourage (parenti, vicini, amici) abbiano subito corruzione; l'aver assistito a scambi illeciti di denaro o favori nel proprio ambiente lavorativo; il voto di scambio alle elezioni amministrative, politiche ed europee; la percezione della diffusione della corruzione nell'ambiente delle imprese e della libera professione. Nella edizione del 2022-2023 è stata aggiunta una batteria di quesiti che rilevano la tolleranza verso la corruzione e la ineluttabilità della stessa.
Nei quesiti utilizzati ci si rivolge all'intervistato domandando se qualcuno ha chiesto a lui o ad altri della sua famiglia, direttamente, o indirettamente tramite intermediari, o se gli è stato suggerito o se gli è stato fatto capire, che pagando denaro extra, o facendo regali, o favori, avrebbe avuto in cambio le agevolazioni o i servizi richiesti. Lo scambio è quindi ben messo in evidenza, anche se viene ricostruita in modo più soft la situazione tipo. Infatti i quesiti sono adattati ai diversi contesti e ai possibili attori della corruzione, come di seguito viene riportato nell'esempio nell'ambito sanitario e lavorativo.
In ambito sanitario:
È mai capitato a lei o a qualcuno dei familiari che vivono con lei, quando avete avuto bisogno di fare una visita medica, un accertamento diagnostico, un ricovero o un intervento che, per ottenere o velocizzare il servizio o per assisterla, un medico, un infermiere o qualcun altro del personale sanitario, vi abbia fatto capire, vi abbia suggerito o vi abbia chiesto, direttamente o tramite altre persone denaro extra, un regalo o altri favori?
E vi è mai capitato che, in una struttura sanitaria pubblica, un ginecologo, un'ostetrica, un chirurgo, un anestesista vi abbiano chiesto denaro per assistervi o operarvi?
In ambito lavorativo:
Ora parliamo del lavoro. È mai capitato a lei o a qualcuno dei familiari che vivono con lei, quando avete cercato un lavoro, partecipato a concorsi pubblici, o cercato di avviare un'attività lavorativa che qualcuno vi abbia fatto capire o vi abbia suggerito o chiesto, anche tramite altre persone, denaro, regali o altri favori?
E le è mai capitato che le chiedessero denaro o altro per avere promozioni, trasferimenti di sede o altre agevolazioni nel lavoro?
Le caratteristiche dell'indagine
Il modulo sulla corruzione è inserito nella indagine sulla sicurezza dei cittadini.
La rilevazione sulla sicurezza dei cittadini è una indagine campionaria condotta mediante interviste agli individui dai 14 anni in su.
L'indagine, denominata "Multiscopo sulle famiglie: Sicurezza dei cittadini", IST - 01863, è prevista dal Programma statistico nazionale 2022-2024 (https://www.sistan.it/index.php?id=52).
L'Indagine è di tipo trasversale a cadenza quinquennale e ha la finalità di conoscere la dimensione e la diffusione del fenomeno della criminalità, le conseguenze di alcuni reati e la percezione che i cittadini hanno della loro sicurezza nei luoghi in cui vivono. Sono presi in considerazione un numero definito di reati contro il patrimonio e contro la persona che hanno come vittime gli individui e le famiglie e per i quali possono essere individuati dei parametri oggettivi di rilevazione.
Cadenza e periodo di rilevazione
La rilevazione è stata effettuata tra novembre 2022 e luglio 2023. Tra il 2022 e il 2023 sono stati intervistati 24.915 individui dai 18 agli 80 anni sia mediante intervista telefonica sia faccia a faccia. L'intervistato è stato chiamato a rispondere ad episodi di cui lui stesso o la sua famiglia sono stati protagonisti.
Le edizioni precedenti sono state ripetute ogni 5/6 anni a partire dal 1997-1998.
Popolazione di riferimento
La popolazione di interesse è costituita dagli individui residenti in Italia (sono escluse le persone che risiedono in istituti di convivenza).
Strumenti di rilevazione
La raccolta dati si è svolta con tecnica mista Cati-Capi.
Taluni quesiti della rilevazione, a causa della difficoltà nella risposta da fornire o della sensibilità dell'argomento trattato, prevedono la facoltà di non rispondere.
Ulteriori informazioni sull'indagine sulla sicurezza dei cittadini e il questionario utilizzato per la raccolta dei dati sono disponibili al seguente link: http://www.istat.it/it/archivio/164581.
La strategia di campionamento e il livello di precisione dei risultati
La popolazione di interesse dell'indagine è costituita dalle famiglie residenti in Italia e dagli individui di 14 anni e più che le compongono. Sono esclusi gli individui che sono membri permanenti delle convivenze. Per famiglia si intende la famiglia di fatto, ovvero un insieme di persone coabitanti e legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi.
L'indagine è di tipo trasversale e ha la finalità di fornire stime di parametri di diversa natura (totali, medie, rapporti, frequenze assolute e relative), riferite alle famiglie e/o agli individui, con diversi riferimenti territoriali:
- l'intero territorio nazionale;
- le cinque ripartizioni geografiche (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole);
- le regioni geografiche;
- cinque aree basate sulla tipologia socio-demografica dei comuni, così definite:
- A, area metropolitana suddivisa in:
- A1, comuni centro dell'area metropolitana: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari;
- A2, comuni che gravitano intorno al centro dell'area metropolitana;
- B, area non metropolitana suddivisa in:
- B1, comuni aventi fino a 2.000 abitanti;
- B2, comuni con 2001-10.000 abitanti;
- B3, comuni con 10.001-50.000 abitanti;
- B4, comuni con oltre 50.000 abitanti.
La progettazione dell'indagine ha considerato come lista della popolazione di interesse l'archivio unificato delle anagrafi comunali (LAC, liste anagrafiche comunali) annualmente raccolte dall'Istat, che ha consentito di basare il campionamento su una lista delle unità appartenenti alla popolazione non affetta da errori di copertura.
Per quanto riguarda la tecnica di indagine la progettazione dell'indagine ha seguito la metodologia utilizzata per l'edizione precedente dell'indagine ed è stata pertanto basata sull'utilizzo di una doppia tecnica di rilevazione delle famiglie, a seconda della presenza o meno di un recapito telefonico. Pertanto, a partire dalla lista relativa alla popolazione di interesse, sono stati individuati due collettivi che costituiscono una partizione dell'intera popolazione obiettivo: sul collettivo delle famiglie a cui è associato un numero di telefono è stata condotta un'indagine con intervista CATI, mentre sul collettivo delle famiglie senza un recapito telefonico la rilevazione è stata condotta mediante intervista faccia a faccia con tecnica CAPI, somministrato da intervistatrici appositamente formate.
La partizione della popolazione in due sotto-popolazioni su cui utilizzare tecniche di rilevazioni differenti ha determinato la necessità di utilizzare sui due collettivi due disegni di campionamento differenti: per la popolazione degli individui con telefono, non sussistendo la necessità di concentrare il campione sul territorio, è stato possibile definire, come fatto per le precedenti edizioni dell'Indagine, un disegno di campionamento ad uno stadio stratificato; per gli individui senza telefono, invece, è stato necessario utilizzare un disegno a due stadi (in cui le unità di primo stadio sono i comuni) come è solitamente necessario fare quando l'intervista deve avvenire faccia a faccia.
È utile ricordare che, in generale, utilizzare un disegno di campionamento ad uno stadio stratificato è preferibile perché determina un guadagno nell'efficienza delle stime rispetto ad un disegno a due stadi, nel quale le stime risentono dell'associazione tra le unità appartenenti stesso comune. In questo caso tuttavia, la scelta di un disegno a due stadi è una scelta obbligata ma ha costituito una soluzione per ridurre l'impatto distorsivo derivante dalla forte sottocopertura della popolazione con telefono rispetto al totale della popolazione italiana.
Disegno di campionamento
Lista di campionamento, informazioni disponibili per lo studio del disegno e numerosità campionaria
L'archivio unificato delle anagrafi comunali contiene le informazioni degli individui e delle famiglie residenti sul territorio italiano: per ciascun individuo sono riportate, oltre alle variabili identificative - compreso il codice fiscale - l'indirizzo, la data di nascita, il sesso, la cittadinanza e l'anno di iscrizione in anagrafe. Tale archivio è stato agganciato alla lista dei numeri di telefono di telefonia fissa SEAT-Consodata.
La prestabilita dimensione campionaria complessiva di circa 31.000 interviste individuali è stata suddivisa in circa 13.000 interviste CATI e 18.000 CAPI, al fine di mantenere una sostanziale proporzione nell'allocazione del campione, dal momento che la popolazione con disponibilità di recapito telefonico rappresenta circa il 30% del totale.
Per entrambi i disegni campionari è stata utilizzata la stratificazione definita dall'incrocio della regione e le sei tipologie comunali definite precedentemente.
Il disegno campionario per la popolazione con telefono
Per la parte di popolazione a cui è associato un numero di telefono, è stato utilizzato un disegno a uno stadio stratificato. Gli strati sono definiti dall'incrocio della regione e della tipologia comunale, ottenendo un numero complessivo di strati pari a 104. La numerosità campionaria di 13.000 individui è stata suddivisa tra le regioni in un'ottica di compromesso tra un'allocazione uguale e una proporzionale, come fatto per le precedenti edizioni dell'indagine, mentre all'interno delle regioni la numerosità è stata suddivisa tra le tipologie comunali in modo proporzionale alla popolazione di 14 anni e oltre presente nelle famiglie con telefono.
All'interno degli strati le unità campionarie, ossia gli individui di 14 anni e più, sono state selezionate con probabilità uguali e senza reimmissione, mediante tecnica di selezione sistematica. Le numerosità campionarie del campione relativo alle interviste CATI per regione sono riportate nel prospetto 1.
Il disegno campionario per la popolazione senza telefono
Descrizione generale del disegno di campionamento
La numerosità campionaria di 18.000 individui attribuita alla parte CAPI dell'indagine è stata suddivisa tra le regioni in un'ottica di compromesso tra un'allocazione uguale e una proporzionale, mentre all'interno delle regioni la numerosità è stata suddivisa tra le tipologie comunali in modo proporzionale alla popolazione di 14 anni e oltre presente nelle famiglie senza telefono, come fatto per la parte CATI dell'indagine.
Il disegno di campionamento è di tipo complesso e si avvale di due differenti schemi di campionamento. Nell'ambito di ognuno dei domini definiti dall'incrocio della regione geografica con le cinque aree A1, A2, B1, B2, B3 e B4, i comuni italiani sono suddivisi in due sottoinsiemi sulla base della popolazione residente in famiglie senza telefono:
- l'insieme dei comuni Auto Rappresentativi (che indicheremo d'ora in avanti come comuni AR) costituito dai comuni di maggiore dimensione demografica;
- l'insieme dei comuni Non Auto Rappresentativi (o NAR) costituito dai rimanenti comuni.
Nell'ambito dell'insieme dei comuni AR, ciascun comune viene considerato come uno strato a se stante e viene adottato un disegno a uno stadio stratificato.
Nell'ambito dei comuni NAR viene adottato un disegno a due stadi con stratificazione delle unità primarie. Le Unità Primarie (UP) sono i comuni, le Unità Secondarie sono gli individui di 14 anni e più.
I comuni vengono selezionati con probabilità proporzionali alla loro dimensione demografica e senza reimmissione, mentre gli individui vengono estratti con probabilità uguali.
Stratificazione e selezione delle unità campionarie
All'interno dei domini definiti dall'incrocio di regione e tipologia comunale i comuni vengono stratificati in base alla loro dimensione demografica (definita in termini di individui delle famiglie senza telefono) nel rispetto delle seguenti condizioni:
- autoponderazione del campione a livello regionale;
- selezione di comuni campione nell'ambito di ciascuno strato definito sui comuni dell'insieme NAR;
- scelta di un numero minimo di individui da intervistare in ciascun comune campione; per l'indagine in oggetto tale numero è stato diversificato tra regioni e tipologie comunali ed è stato posto pari a 26 per la maggior parte delle regioni medio grandi, mentre per le regioni di dimensione demografica minore (Valle d'Aosta, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Bolzano e Trento) è stato posto pari a 22 (16 per la tipologia B3);
- formazione di strati aventi ampiezza approssimativamente costante in termini di popolazione. Il procedimento di stratificazione, si articola nelle seguenti fasi:
- ordinamento dei comuni del dominio in ordine decrescente secondo la loro dimensione;
- determinazione di una soglia di popolazione per la definizione dei comuni AR, mediante la relazione:
in cui per la generica regione geografica d si è indicato con: il numero minimo di interviste in ciascun comune campione; df la frazione di campionamento a livello del dominio d;
- suddivisione di tutti i comuni nei due sottoinsiemi AR e NAR: i comuni di dimensione superiore o uguale a
dλ sono definiti come comuni AR e i rimanenti come NAR;
- suddivisione dei comuni dell'insieme NAR in strati aventi dimensione, in termini di popolazione residente, approssimativamente costante e all'incirca pari a dλ .
Effettuata la stratificazione, i comuni AR sono inclusi con certezza nel campione; per quanto riguarda, invece, i comuni NAR, nell'ambito di ogni strato viene estratto un comune campione con probabilità proporzionale alla dimensione demografica, mediante la procedura di selezione sistematica proposta da Madow [3]. Gli individui sono estratti in modo sistematico dalla lista degli individui senza telefono di ciascun comune.
La realizzazione del disegno campionario ha previsto una dimensione effettiva del campione di 18.000 individui distribuiti in 680 comuni. Le numerosità campionarie di comuni e individui del campione per le interviste CAPI per regione sono riportate nel prospetto 1.
Prospetto 1. Distribuzione regionale del campione effettivo CATI di individui e del campione effettivo CAPI di comuni e individui
REGIONI
Individui del campione CATI
Comuni campione CAPI
Individui del campione CAPI
Piemonte
551
37
875
Valle d'Aosta
262
15
429
Lombardia
979
59
1484
Bolzano
267
16
339
Trento
335
20
481
Veneto
721
42
1075
Friuli-Venezia Giulia
373
22
580
Liguria
318
16
463
Emilia-Romagna
599
34
1157
Toscana
582
37
885
Umbria
365
21
559
Marche
424
30
665
Lazio
808
39
1224
Abruzzo
426
28
615
Molise
456
22
692
Campania
1011
55
1541
Puglia
582
38
903
Basilicata
385
24
588
Calabria
403
26
621
Sicilia
1108
62
1779
Sardegna
537
37
870
ITALIA
11492
680
17825
Procedimento per il calcolo delle stime
Definizione del sistema di pesi
Le stime prodotte dall'indagine sono stime di frequenze assolute e relative riferite agli individui (variabili definite per fenomeni di tipo individuale) e alle famiglie ad essi associate (variabili definite per fenomeni di tipo familiare).
Le stime sono ottenute mediante uno stimatore di ponderazione vincolata, che è il metodo di stima standard per la maggior parte delle indagini Istat sulle imprese e sulle famiglie.
Il principio su cui è basato ogni metodo di stima campionaria è che le unità appartenenti al campione rappresentino anche le unità della popolazione che non sono incluse nel campione.
Questo principio viene realizzato attribuendo ad ogni unità campionaria un peso che indica il numero di unità della popolazione rappresentate dall'unità medesima. Se, ad esempio, ad un'unità campionaria viene attribuito un peso pari a 100, vuol dire che questa unità rappresenta se stessa ed altre 99 unità della popolazione che non sono state incluse nel campione.
Al fine di rendere più chiara la successiva esposizione, introduciamo la seguente simbologia: d, indice di livello territoriale di riferimento delle stime; h, indice di strato (che indica per il disegno CATI il dominio definito dall'incrocio di regione e tipologia comunale e per la parte CAPI lo strato dei comuni all'interno del medesimo dominio); j, indice di famiglia; q indice di individuo all'interno della famiglia; y, generica variabile oggetto di indagine; Yhjq valore di y osservato sull'individuo q della famiglia j dello strato h; Qhj, numero di individui di 14 anni e oltre appartenenti alla famiglia j dello strato h; Mh, numero di famiglie residenti nello strato h; mh, campione di famiglie nello strato h; qh, numero di individui campione nello strato h; Hd, numero di strati nel dominio di interesse d. Per semplicità si omette per il momento l'indice di comune i appartenente allo strato h, che deve essere considerato solamente per la parte di campione selezionato mediante disegno a due stadi.
Ipotizziamo di voler stimare, con riferimento ad un generico dominio d (ad esempio una regione geografica) il totale della variabile y oggetto di indagine riferita agli individui (ad esempio il numero totale di scippi subiti dagli individui di 14 anni e oltre), espresso dalla seguente relazione:
Una stima del totale (1) è data dalla seguente espressione:
in cui yhj e whj rappresentano rispettivamente il valore assunto dalla variabile y e il peso finale da attribuire all'individuo campione i dello strato h.
Dalla precedente relazione si desume, quindi, che per ottenere la stima del totale (1) occorre moltiplicare il peso finale associato a ciascuna unità campionaria per il valore della variabile y assunto da tale unità ed effettuare, a livello del dominio di interesse, la somma dei prodotti così ottenuti.
Il peso da attribuire alle unità campionarie è ottenuto per mezzo di una procedura complessa che ha le seguenti finalità: correggere l'effetto distorsivo dovuto agli errori di lista e al fenomeno della mancata risposta totale; tenere conto della conoscenza di alcuni totali noti sulla popolazione oggetto di studio, nel senso che le stime campionarie di tali totali devono coincidere con i rispettivi valori noti.
La procedura per la costruzione dei pesi finali da attribuire alle unità campionarie, è articolata in due distinte fasi:
Fase 1. Il peso diretto è ottenuto come reciproco della probabilità di inclusione di ogni unità campionaria nel campione.
Fase 2. I pesi ottenuti al passo 1 vengono calibrati considerando congiuntamente i due campioni CATI e CAPI, rispetto a totali noti calcolati sulla popolazione complessiva per i quali sono disponibili dati più aggiornati da fonte demografica e/o da altre indagini.
Per questa indagine sono stati calcolati due sistemi di pesi differenti per la produzione delle stime riferite agli individui e alle famiglie.
Calcolo dei pesi diretti
Il peso diretto individuale viene calcolato in maniera differente a seconda della modalità di rilevazione, CATI o CAPI che determina un diverso disegno di campionamento. Relativamente al disegno CAPI, siano: il numero di individui senza telefono dello strato h, , il numero di individui senza telefono nel comune i, dello strato h; il numero di individui eleggibili residenti nel comune i dello strato h, , il numero di individui senza telefono campione selezionati nel comune i dello strato h. Relativamente al disegno CATI siano invece: , il numero di individui con telefono nello strato h; , il numero di individui campione con telefono selezionate nello strato h. I pesi diretti per CATI e CAPI vengono calcolati rispettivamente come:
- dove πih è la probabilità di inclusione del comune i dello strato k.
Il peso a livello familiare si ottiene in entrambi i casi dividendo i pesi individuali così ottenuti per il numero di componenti eleggibili della famiglia osservata:
Calcolo dei pesi finali
Per la calibrazione dei pesi individuali la popolazione di riferimento è costituita dagli individui di 14 anni e oltre. I totali noti imposti a livello regionale sono i seguenti:
a. popolazione per sesso e classi di età (14-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75 e oltre);
b. popolazione per tipologia comunale (aree A1, A2, B1, B2, B3, B4 definite nel paragrafo 1);
c. popolazione per cittadinanza (italiano/straniero);
d. popolazione per titolo di studio (1 - fino alle medie, 2 - superiori, 3 - laurea ed oltre);
e. popolazione per dimensione familiare (famiglie monocomponenti per sesso ed età (14-64, 65 e oltre), 2 componenti, 3-4 componenti, 5 e più componenti).
Per la calibrazione dei pesi a livello familiare, la popolazione di riferimento è costituita dall'intera popolazione residente e i totali noti a livello di regione sono i seguenti:
a. popolazione per sesso e classi di età (0-13,14-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75 e oltre);
b. popolazione per tipologia comunale;
c. popolazione per dimensione familiare (famiglie monocomponenti per sesso ed età (14-64, 65 e oltre), 2 componenti, 3-4 componenti, 5 e più componenti).
È utile osservare che i vincoli relativi al titolo di studio e alla dimensione delle famiglie sono stati introdotti nonostante il fatto che non si basino su totali noti da fonte censuaria o anagrafica, ma su stime prodotte da indagini campionarie, l'indagine sulle forze di lavoro (FOL). Si è comunque ritenuto opportuno utilizzarli per correggere la distorsione dovuta alla mancata risposta totale, considerando anche il fatto che le indagini a cui si ricorre sono basate su campioni di dimensione sufficiente per garantire stime affidabili.
In tutti i passi di calibrazione i fattori correttivi sono ottenuti dalla risoluzione di problemi di minimo vincolato, in cui la funzione da minimizzare è una funzione di distanza (opportunamente prescelta) tra i pesi base e i pesi finali e i vincoli sono definiti dalla condizione di uguaglianza tra stime campionarie dei totali noti e i valori noti degli stessi. La funzione di distanza prescelta è la funzione logaritmica troncata; l'adozione di tale funzione garantisce che i pesi finali siano positivi e contenuti in un predeterminato intervallo di valori possibili.
Tutti i metodi di stima che scaturiscono dalla risoluzione di un problema di minimo vincolato del tipo sopra descritto rientrano in una classe generale di stimatori nota come stimatori di ponderazione vincolata [4]. Un importante stimatore appartenente a tale classe, che si ottiene utilizzando la funzione di distanza euclidea o lineare, è lo stimatore di regressione generalizzata. Come verrà chiarito meglio nel paragrafo 4, tale stimatore riveste un ruolo centrale perché è possibile dimostrare che tutti gli stimatori di ponderazione vincolata convergono asintoticamente, all'aumentare della numerosità campionaria, allo stimatore di regressione generalizzata.
4. Valutazione del livello di precisione delle stime
Le principali statistiche di interesse per valutare la variabilità campionaria delle stime prodotte dall'indagine sono l'errore di campionamento assoluto e l'errore di campionamento relativo.
Indicando con la varianza della stima , riferita al dominio d, la stima dell'errore di campionamento assoluto di si può ottenere mediante la seguente espressione:
La stima dell'errore di campionamento relativo di , è invece definita dall'espressione:
Come è stato descritto nel paragrafo precedente, le stime prodotte dall'indagine sono state ottenute mediante uno stimatore di calibrazione in due passi sulla base di una funzione di distanza di tipo logit. Poiché lo stimatore adottato non è funzione lineare dei dati campionari non è possibile ottenere una espressione analitica per la stima della varianza. Pertanto si è utilizzato il metodo proposto da Woodruff [5] che, ricorrendo all'espressione linearizzata in serie di Taylor, consente di ottenere la varianza di ogni stimatore non lineare calcolando la varianza dell'espressione linearizzata ottenuta. Tale metodologia di stima della varianza è implementata nel software generalizzato ReGenesees [6], che è stato utilizzato per la stima della varianza delle stime.
Gli errori campionari delle espressioni (5) e (6), consentono di valutare il grado di precisione delle stime; inoltre, l'errore assoluto permette di costruire l'intervallo di confidenza, che, con una certa probabilità, contiene il parametro d'interesse. Con riferimento alla generica stima tale intervallo assume la seguente forma:
Nella (7) il valore di k dipende dal valore fissato per la probabilità P; ad esempio, per P=0,95 si ha k=1,96.
Presentazione sintetica degli errori campionari
Premessa
Ad ogni stima è associato un errore campionario relativo ; quindi, per consentire un uso corretto delle stime fornite dall'indagine, sarebbe necessario presentare, per ogni stima pubblicata, anche il corrispondente errore di campionamento relativo.
Ciò, tuttavia, non è possibile, sia per limiti di tempo e di costi di elaborazione, sia perché le tavole della pubblicazione risulterebbero eccessivamente appesantite e di non agevole consultazione per l'utente finale. Inoltre, non sarebbero in ogni caso disponibili gli errori delle stime non pubblicate, che l'utente può ricavare in modo autonomo.
Per questi motivi, generalmente, si ricorre ad una presentazione sintetica degli errori relativi, basata sul metodo dei modelli regressivi. Tale metodo si fonda sulla determinazione di una funzione matematica che mette in relazione ciascuna stima con il proprio errore relativo.
L'approccio utilizzato per la costruzione di questi modelli è diverso a seconda che si tratti di variabili qualitative o quantitative. Infatti, nel caso delle stime di frequenze assolute (o relative) riferite alle modalità di variabili qualitative, è possibile utilizzare dei modelli che hanno un fondamento teorico e secondo cui gli errori relativi delle stime di frequenze assolute sono funzione decrescente dei valori delle stime stesse. Per quanto riguarda, invece, le stime di totali di variabili quantitative, si tratta di un problema di notevole complessità, che può essere risolto in maniera empirica adattando diversi modelli regressivi ai dati osservati e scegliendo tra i modelli stimati quello che conduce ad un R2 maggiore.
Presentazione sintetica degli errori campionari per stime di frequenze
Il modello utilizzato per le stime di frequenze assolute, con riferimento al generico dominio d, è il seguente:
dove log indica il logaritmo in base naturale e i parametri a e b vengono stimati mediante il metodo dei minimi quadrati.
Il prospetto 2 riporta i valori dei coefficienti a e b e dell'indice di determinazione R2 del modello utilizzato per l'interpolazione degli errori campionari delle stime di frequenze riferite alle famiglie e alle persone, per aree territoriali.
Sulla base delle informazioni contenute nel suddetto prospetto è possibile calcolare l'errore relativo di una determinata stima di frequenza assoluta , riferita ai diversi domini, mediante la formula:
e costruire l'intervallo di confidenza al 95% come:
Allo scopo di facilitare il calcolo degli errori campionari, nei prospetti 3 e 4 sono riportati, gli errori relativi percentuali corrispondenti a valori crescenti di stime di frequenze assolute riferite, rispettivamente, alle famiglie e alle persone, calcolati introducendo nella (9) i valori di a e b riportati nel prospetto 2.
Le informazioni contenute in tali prospetti consentono di calcolare l'errore relativo di una generica stima di frequenza assoluta mediante due procedimenti di facile applicazione che, tuttavia, conducono a risultati meno precisi di quelli ottenibili applicando direttamente la formula (9).
Il primo metodo consiste nell'approssimare l'errore relativo della stima di interesse con quello, riportato nei prospetti, corrispondente al livello di stima che più si avvicina a .
Il secondo metodo, più preciso del primo, si basa sull'uso di una formula di interpolazione lineare per il calcolo degli errori di stime non comprese tra i valori forniti nei prospetti. In tal caso, l'errore campionario della stima , si ricava mediante l'espressione:
dove e sono i valori delle stime entro i quali è compresa la stima , mentre e sono i corrispondenti errori relativi.
Scarica il file
L'output: principali indicatori e unità di misura
L'Indagine sulla sicurezza dei cittadini ha l'obiettivo di produrre stime sulla prevalenza di vittime di reati contro il patrimonio e contro la persona, fornisce gli indicatori sulla percezione della sicurezza, sui sistemi di difesa dell'abitazione e sul degrado sociale della zona in cui si vive.
Inoltre contribuisce alla produzione dei dati per gli indicatori SDGs, goal 16 https://www.istat.it/it/benessere-esostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/il-rapporto-sdgs e il dominio sicurezza del rapporto sul Benessere, https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)/il-rapporto-istat-sul-bes.
Vittime, reati e percezione di sicurezza
http://www.istat.it/it/archivio/4089
Molestie sessuali
http://www.istat.it/it/archivio/5173
Il disagio nelle relazioni lavorative
http://www.istat.it/it/archivio/5191
La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie
http://www.istat.it/it/files/2017/10/La-corruzione-in-Italia.pdf
Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro
http://www.istat.it/it/archivio/209107
Reati contro la persona e contro la proprietà: vittime ed eventi
https://www.istat.it/it/archivio/226696
Rapporto Bes
https://www.istat.it/it/files//2024/04/Bes-2023-Ebook.pdf
Istat, La Sicurezza dei Cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione, Istat, collana informazioni, n. 18, 2004
[3] Madow, W.G. (1949) "On the theory of systematic sampling II", Ann. Math. Stat., 20, 333-354
[4] Deville J.C. e Sarndäl C.E. (1992), "Calibration Estimators in Survey Sampling", Journal of the American Statistical Association 87: 376-382.
[5] Woodruff R.S. (1971), A Simple method for approximating the variance of a complicate estimate, Journal of the American Statistical Association, 66, pp 411-414.
[6] Zardetto D. (2015), ReGenesees: an Advanced R System for Calibration, Estimation and Sampling Error Assessment in Complex Sample Surveys, Journal of Official Statistics, Vol. 31, No. 2, 2015, pp. 177-203
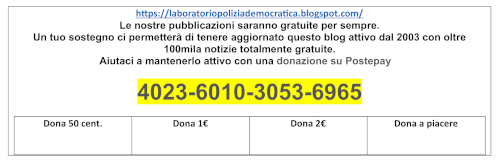
Nessun commento:
Posta un commento